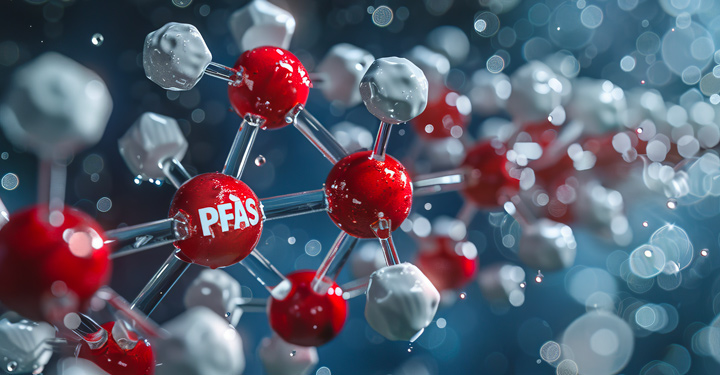Le centrali idroelettriche rappresentano una delle principali fonti di energia rinnovabile in Italia, con una produzione annua di circa 30.000 GWh. Tuttavia, la sicurezza di queste strutture è un tema cruciale, soprattutto alla luce di incidenti significativi come quello avvenuto il 9 aprile 2024 alla centrale di Bargi, nel lago di Suviana, che ha provocato la morte di cinque operai impegnati nella manutenzione dell’impianto.
Rischi per i lavoratori
I principali rischi per i lavoratori nelle centrali idroelettriche sono legati alle attività di manutenzione e operazione degli impianti. Questi includono:
- Cadute e scivolamenti: spesso dovuti a superfici bagnate o irregolari.
- Rischio elettrico: derivante dall’interazione con impianti sotto tensione.
- Rischi chimici: esposizione a sostanze pericolose utilizzate nei processi di trattamento.
- Uso di attrezzature a pressione: come valvole e tubazioni ad alta pressione.
- Elevati livelli di rumore: provenienti dalle turbine e altri macchinari.
Inoltre, la difficoltà di accesso alle centrali, spesso situate in zone remote, può complicare le operazioni di emergenza e evacuazione.
Misure di sicurezza e prevenzione
Per garantire la sicurezza nelle centrali idroelettriche, sono previste diverse misure:
- Monitoraggio continuo: utilizzo di sensori per il controllo dei livelli idrici, della stabilità dei versanti e delle condizioni geomorfologiche.
- Verifiche periodiche: controlli regolari su dighe, sbarramenti e condotte forzate per assicurare la loro integrità strutturale.
- Formazione del personale: addestramento continuo per i lavoratori riguardo alle procedure di sicurezza e gestione delle emergenze.
- Piani di emergenza: elaborazione di strategie per affrontare situazioni critiche, inclusi incendi e malfunzionamenti degli impianti.
L’INAIL, attraverso il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, svolge un ruolo fondamentale nella supervisione e nel controllo delle misure di sicurezza nelle centrali idroelettriche.
Il problema dell’età degli impianti
Un aspetto critico per la sicurezza delle centrali idroelettriche italiane è l’età avanzata di molti impianti. Circa il 70% delle centrali ha più di 40 anni, il che comporta un aumento dei rischi legati all’usura e alla necessità di manutenzione straordinaria. Tuttavia, gli incentivi per il ripotenziamento degli impianti sono limitati, rendendo difficile affrontare adeguatamente questo problema.
Conclusioni
La sicurezza nelle centrali idroelettriche italiane è una priorità che richiede attenzione costante e investimenti adeguati. È essenziale implementare misure preventive efficaci, garantire la formazione continua del personale e affrontare il problema dell’età degli impianti per ridurre i rischi e proteggere la vita dei lavoratori.