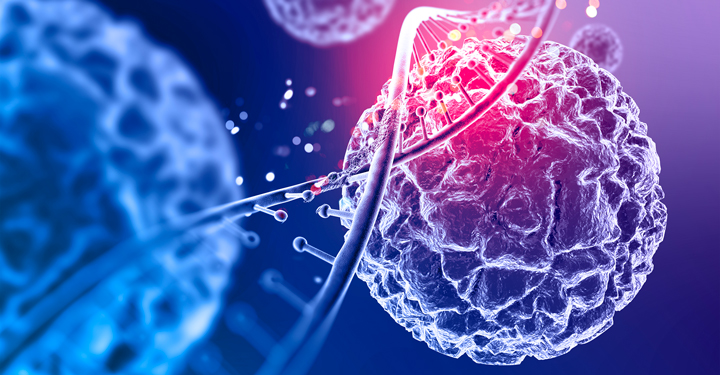La gestione agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro è disciplinata dal quadro normativo definito nel Titolo IX, capo II, del Dlgs 81/2008. Questo corpus legislativo stabilisce gli obblighi minimi di protezione per i lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti, o che possono derivare, dall’esposizione a tali sostanze, note per la loro capacità di causare danni a lungo termine e patologie irreversibili.
La normativa non è statica; essa recepisce costantemente gli aggiornamenti provenienti dall’unione europea, che aggiornano gli elenchi delle sostanze e i relativi valori limite. Un esempio è la Direttiva (UE) 2022/431, quarta modifica della Direttiva 2004/37/CE, che ha introdotto nuove sostanze nell’elenco degli agenti nocivi e rivisto i valori limite di esposizione professionale per altri. Questi recepimenti, come avvenuto con il Dlgs 44/2020 che ha modificato il Testo Unico, impongono ai datori di lavoro un processo di adeguamento continuo e proattivo della valutazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione, assicurando che la protezione sia sempre allineata alle più recenti evidenze scientifiche.
Le misure di prevenzione per la gestione agenti cancerogeni
Il fulcro della normativa risiede nell’articolo 236 del Dlgs 81/08, che impone al datore di lavoro una valutazione approfondita, specifica e documentata dell’esposizione. Qualora da questa emerga la presenza di un agente cancerogeno o mutageno, scattano gli obblighi gerarchici definiti dall’articolo 237.
La priorità assoluta è, ove tecnicamente possibile, l’eliminazione o la sostituzione dell’agente nocivo con una sostanza, una miscela o un processo meno pericoloso. Se la sostituzione non è attuabile, il datore di lavoro deve garantire che la produzione e l’uso avvengano in un sistema chiuso per impedire ogni contatto. Laddove anche questo non fosse possibile, l’esposizione dei lavoratori deve essere ridotta al più basso valore tecnicamente raggiungibile, agendo prima sulle misure di protezione collettiva, come la ventilazione localizzata, e solo come ultima ratio sui dispositivi di protezione individuale (DPI). A ciò si affiancano misure organizzative cruciali: dalla limitazione del numero di addetti esposti alla definizione di aree di rischio specifiche e segnalate, accessibili solo al personale autorizzato. Completano il quadro le misure igieniche (divieto di fumare, bere o mangiare nelle aree a rischio), la predisposizione di procedure per le emergenze e l’informazione e formazione specifica dei lavoratori.
Sorveglianza sanitaria e obblighi post-esposizione
Una conseguenza diretta della valutazione del rischio è l’attivazione della sorveglianza sanitaria, disciplinata dall’articolo 238. Questa diventa obbligatoria per tutti i lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute, anche qualora l’esito della valutazione non indichi un livello di rischio significativo. Il medico competente, come previsto dall’articolo 239, istituisce e aggiorna per ogni lavoratore esposto una cartella sanitaria e di rischio, che deve essere conservata con cura. L’articolo 240 specifica ulteriormente questo adempimento, richiedendo la creazione di un registro dei lavoratori esposti, indicando l’attività svolta, l’agente utilizzato e, se noto, il livello di esposizione.
L’aspetto più qualificante della normativa, tuttavia, è definito dall’articolo 242, che estende la sorveglianza sanitaria anche dopo la cessazione dell’esposizione. I lavoratori hanno il diritto di continuare a sottoporsi a controlli medici anche dopo la fine del rapporto di lavoro, secondo le indicazioni del medico competente o della normativa vigente. Questo obbligo di monitoraggio a lungo termine è fondamentale per intercettare precocemente le patologie a lunga latenza tipiche dell’esposizione a tali agenti, garantendo una tutela che va oltre la durata del contratto.